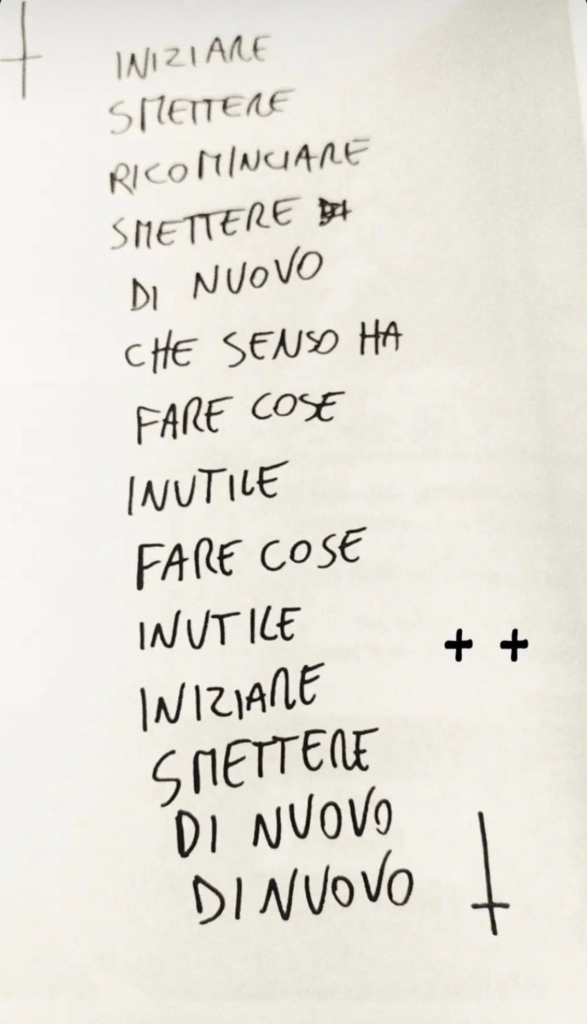Non c’è un altro posto in cui vorremmo essere a fine Giugno (a parte Auburn, ovviamente), perchè non c’è un altro evento di Ultra Trail in Italia che sia riuscito a farci raccogliere così tanti ricordi, felici e sofferti, come Lavaredo Ultra Trail. Anche questa edizione la Crew di DU torna tra le Dolomiti ad assistere atleti e amici, in quello che si prospetta diventare un appuntamento cardine di quest’ anno di Coaching.

Lavaredo Ultra Trail non richiede presentazioni vista la storicità che ricopre nell’ambiente delle Ultra: è un evento delle grandi tradizioni che comunque ha visto una sua evoluzione negli anni, configurandosi come una tappa, finale o intermedia, sul cammino di preparazione di tanti atleti ogni anno. Con le distanze canoniche che spaziano dalla 20 ai 50 km (aka Skyrace e Cortina Trail) fino ai 120 km (la LUT), arricchite negli ultimi anni da una 80 km (Ultradolomites) e una veloce 10 su strade bianche, è a tutti gli effetti un evento che raccoglie corridori di ogni livello e aspirazione. Ci aggiungiamo che la difficoltà media dei percorsi è bassa e che tutti i tracciati consentono di assaporare i migliori sentieri dell’arco Ampezzano, e il risultato è una partecipazione massiva e la evidenzia come gara da Bucket List.
L’avvicinamento all’evento
Un evento con queste premesse ci ha convinti 4 anni fa a creare un percorso di preparazione particolarmente dedicato, sia per gli atleti del coaching personalizzato 1-1 che per i partecipanti ai programmi di allenamento del Cortina Training Plan. In entrambi i servizi abbiamo accompagnato gli atleti, rispettivamente in maniera più o meno personalizzata, in un approccio diretto alle gare di Cortina, grazie alla particolare posizione sulla metà anno che consente un lavoro mirato di 6 mesi. Studiato a puntino, sia nelle proposte di gare di avvicinamento che degli opportuni blocchi di allenamento pensati in direzione di una gara di media e lunga distanza in Dolomiti, a fine Giugno, abbiamo arricchito il percorso di avvicinamento con
- 5 Webinars dedicati ai maggiori aspetti della preparazione aperti a tutti gli atleti interessati all’evento, dallo Strenght & Conditioning all’integrazione per sport di resistenza, dalle considerazioni sui materiali più adatti fino ad una curata analisi del percorso di ogni distanza e delle casistiche di gestione del giorno gara.
- Long Runs di gruppo, due, per fare dei lunghi preparatori specifici a Febbraio e Maggio: poter vedere gli atleti di persona muoversi sui sentieri, fare valutazioni assieme sugli step fatti e quelli ancora da aggiustare in vista dell’evento di elezione, e poi per il motivo più importante: fare gruppo e creare quella facilità di dinamiche e situazioni familiari che fan volare le ore di allenamento.
- Training Camp, quest’anno nell’Alto Garda, dove con più di 30 atleti abbiamo finalizzato gli ultimi aspetti tecnici dell’avvicinamento alla gara e messo assieme un buon weekend di volume tra le vette trentine.


Specificità
Rispetto agli anni scorsi, quest’anno abbiamo posto particolare attenzione sullo sviluppo per tutti di un piano d’Integrazione flawless approfondito con gli interventi di una professionista del settore (say hi to Sara Toloni – Biologa Nutrizionista). Calcare sull’aspetto della nutrizione dentro e fuori il giorno gara è sempre stato un nostro pallino, quest’anno con un accento particolarmente marcato dopo che negli ultimi tempi sul tema c’è stata sempre più discussione (e confusione) alla portata di tutti, con le dovute criticità che la materia si porta dietro. Ci siamo impegnati a tenere le cose utili nel piatto ed eliminare leggende metropolitane e facili imprecisioni, per un allenamento che passasse anche da una giusta integrazione in corsa, e non solo nel volume o la qualità. La collaborazione a stretto contatto con Precision Hydration ci ha aiutati ad avere un supporto solido su cui porre basi non solo di teoria, ma anche di comune pratica nel giorno dei lunghi: provare questo, aumentare quel tipo di introito, tentare un approccio più liquido o uno più solido, ecc. Avere un prodotto affidabile ci ha dato una mano a poter dare una proposta concreta, senza forzature o proposte univoche calate dall’alto.

Ma visto che non solo di carboidrati vive l’uomo, ma anche di pasti a base di volume e dislivello, una grossa parte della specificità della preparazione è passata attraverso il guidare gli atleti attraverso possibili scenari di approccio, fatti a volte di diverse gare di avvicinamento, altre volte di nessuna: ognuno ha fatto un percorso sui generis. Denominatore comune: arrivare a ridosso delle settimane e mesi finali con la voglia di passare ore sulle gambe, portare a casa km negli ambienti giusti e ‘testarsi’ in quei frangenti che il giorno gara saranno messi maggiormente sotto stress. Ultradolomites con la sua prima metà dal dislivello molto concentrato, LUT120k con la duplicità di sezioni corribili alle prime battute, e più muscolari nelle ultime, Cortina Trail con la possibilità di essere l’unica gara a percorrere la temuta Val Travenanzes da freschi. Ogni gara ha avuto una singola attenzione nella gestione delle dovute intensità, e quel che conta di più, nel saper dare il giusto taglio alla costruzione del tempo all’intensità-gara, che chiaramente varia da atleta ad atleta e da distanza a distanza. Non abbiamo la presunzione di aver dato le risposte a tutte le situazioni che ognuno dei nostri atleti si ritroverà ad affrontare tra una settimana, ma di sicuro abbiamo costruito una cassetta degli attrezzi solida da cui prendere il giusto strumento: e non solo dalle fasi finali dell’allenamento. Se ognuno dei nostri guarderà indietro ai mesi passati, riconoscerà che dove si trova adesso è il frutto di tutto quello che è venuto prima: dalla costruzione del volume invernale alla strutturazione dei lavori di forza e velocità, dal lungo blocco di Threshold Training per aumentare la resistenza alla fatica alle fatidiche rifiniture per dare a tutti quella fluidità di corsa che farà mettere il piede sulla start line col sorriso e il cuore leggero:
You’ve done the work…Now, you need to know that shit’s gonna happen. Andy Jones-Wilkins con una delle sue granate pre-WS.
DU Crew e weekend di gara
Non c’è percorso che si rispetti senza una degna conclusione: anche quest’anno tutti i coach tornano sul luogo del delitto per assistere gli atleti (e ogni tanto anche le improvvisate crew di amici e familiari) a sopravvivere al weekend Cortinese. Con circa 80 atleti distribuiti sulle varie distanze, si prospettano giornate (e notti) di sudore per tutti e 7 i coach. Si inizia dalle tradizioni più importanti:
- Giovedì pomeriggio chiacchiere, fun run, e per qualcuno birretta post corsa, con ritrovo e partenza dal Mini-Golf di Cortina. Ci si rivede, si registrano un po’ di vibes dell’ultimo minuto e si smollano i nervi con qualche facile km in compagnia. E sul finale si porta un po’ di tifo ai compagni della Skyrace 20 km. Poi ognuno per sè, specie chi corre al mattino del giorno dopo.
- Venerdì mattina e primo pomeriggio sono dedicati al fu Cortina Trail, con coach presenti in vari punti chiave del percorso. Assistenza non concessa, ma metteremo in gioco le nostre migliori pacche sulle spalle, e un po’ di cazzimma all’occorrenza.
- Venerdì sera e Sabato notte, presenti in partenza ma soprattutto a presidiare la Aid Station di Ospitale, per guardare tutti entrare in gara vera con le migliori intenzioni, e magari senza saltare il ristoro. Chi lo sa, magari da qualche parte della notte un Coach si presenterà anche a Misurina, magari no: occhi aperti.
- Sabato: safari full-contact. Da Cimabanche a Col Gallina fino a Passo Giau, il diabolico piano della DU Crew si concretizzerà ne Il giorno più lungo, per dare a tutti il giusto supporto al momento opportuno. E a ricordare l’adagio ‘A Col Gallina vietato stendersi!’.



Like glue like crew
Crediamo nel valore di quel che offriamo a partire da tutto quello che mettiamo nel concreto di ogni singolo giorno di coaching, in ogni feedback dell’afterhour, in ogni dato sviscerato da Training Peaks. Ma tutto questo non sarebbe possibile, né sufficiente, senza quel legante fondamentale che da spessore al nostro lavoro. Cortina, a fine Giugno, per noi allenatori è il setting perfetto per condividere lo stesso commitment che chiediamo ad ogni singolo atleta nei mesi precedenti alla gara. Gestire ups e downs in una giornata come questa esce molto più facile se al tuo fianco hai qualcuno di fidato che ti ha accompagnato alla meta: l’Ultrarunning è uno sport di testa ed emozioni, a vari livelli, prima di essere una mera disciplina di resistenza. Avere del supporto emotivo aiuta a superare quel momento difficile, magari anche solo fatto di pochi secondi in una gara di 20 ore, senza finire a raschiare il fondo del barile, da solo. Abbiamo dato più calci in culo a Col Gallina negli ultimi anni che in tutte le altre gare messe assieme cui partecipiamo, perchè sappiamo bene che momento delicato possa essere. Abbiamo aspettato atleti ai cut-off e li abbiamo spinti avanti di forza per non gettare alle ortiche una giornata dall’altissimo effort fisico e mentale; per non parlare delle imbeccate alle drop bags di Cimabanche o al final push infuso a Passo Giau. Sentirsi parte di una famiglia così grande, ne siamo certi, ha sempre dato quella marcia in più che vogliamo offrire, e ha dato risultati validati anche dal rate di finishers alle gare: anche quest’anno si mira al clean sweep!
In un anno di Trail ci sono decine di weekend di gara, dentro e fuori Italia, che meritano di essere assistiti e vissuti; Cortina non è tutto rose e fiori, ha le sue criticità e contraddizioni che fanno storcere il naso a molti puristi del nostro sport. Eppure sfiderei chiunque a venire ad uno dei principali ristori di queste gare e non restare affascinato dagli esempi di gaso, determinazione e grinta che suscitano gli atleti coi loro accompagnatori. E noi siamo 100% pronti a mettere la nostra parte.
Preparate la sedia da campeggio e la crema solare.
See you in Cortina.