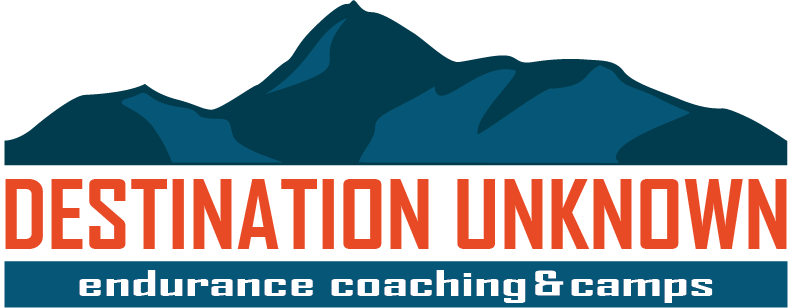FLEX YOUR HEAD
Premessa: spero che ciò che scriverò serva puramente come riflessione. Abbiate l’intelligenza di leggere il tutto per ciò che è: un esercizio di osservazione del mondo in cui opero e lavoro, lo spunto per creare una discussione aperta. Non sono ovviamente uno specialista, ma nonostante la psicologia sportiva in Italia sia assolutamente sottovalutata e poco […]
Transamericana – il film di Rickey Gates
Se penso alla cinematografia del settore outdoor il processo che c’è stato è più o meno questo (sono ovviamente solo esperienze e opinioni personali). Ai tempi delle superiori riuscivo, tramite riviste, fanzine e tante ricerche su qualche rudimentale motore di ricerca, a trovare dei documentari sugli sport di nicchia di allora. Perlopiù tamarrate tipo freestyle […]
R2R2R – Il sogno degli FKT
Se l’ultrarunning fosse solo il tran tran di allenamenti gare allenamenti gare off season allenamenti gare, sarebbe una noia mortale. Per fortuna esistono molte altre realtà nella comunità dei corridori che non hanno a che vedere strettamente con le gare organizzate. Un giorno una persona mi ha detto che tutto l’anno si prepara solo per […]
Ti porto io in un posto figo – parte 1, Repubblica Indipendente di Colferraio
Colferraio, Oregon, ah no, Marche, Italia. Posto sperduto nelle Marche, in provincia di Macerata dove l’autostrada più vicina è a 70 km, così come la prima città grande (Ancona), che è sulla costa ed è quindi terra lontanissima e ha una cultura e modi di fare completamente diversi dalla gente dell’entroterra. Colferraio, il cui nome […]
TOR: ovvero, come rovinare una passeggiata
Partiamo da un assunto che un grande teorico della corsa su lunga distanza ha donato ai posteri: “ se il vincitore ci mette più di 24 ore è solo una gita del CAI” Francesco paco Gentilucci motivo per cui, il TOR, fa schifo.No dai, che adesso tutti saranno lì già pronti a riempirmi la casella […]
Fabio De Boni e l’Everesting del Summano
L’idea è semplice e sognare una cosa del genere è facile da comprendere; realizzarla un altro paio di maniche. Le regole sono semplici: coprire il dislivello positivo dell’Everest (8848 metri) correndo sullo stesso sentiero durante un lasso di tempo continuo (illimitato), ma senza quindi fermarsi mai a dormire. Ora, quale può essere il più bel […]
Che tipo di 100 miglia sei?
Per qualche ragione che non ho mai capito, e forse mai capirò, l’Ultra Trail del Monte Bianco si chiama Ultra Trail del Monte Bianco e non “100 miglia del Monte Bianco”. I chilometri sono più o meno 167, il che corrisponde a 100 miglia. E le 100 miglia nascono ben prima degli Ultra Trail. Ma […]
Sponsorizzazioni for dummies
Forte non sono mai andato. Tuttavia, per il mio lavoro precedente, per amicizie, perché sono un cinico bastardo, e perché mi piace leggere libri sulla psicologia sociale e dello sport, qualcosa di sponsorizzazioni e atleti provo a capirne. Ovviamente questo pezzo non va preso come una dichiarazione di qualche tipo, ma semmai come uno spunto […]
Il sorriso che uccide: Elisabetta Luchese
Una prima metà di stagione intensa, dove la nostra Betta si è fatta conoscere e sentire in tutto il nordest. Ma aldilà dei risultati, ci piaceva farvi conoscere la Betta che c’è dietro ad un podio o un pettorale, e allora Paco ha provato a scavare un po’dietro a quel sorriso: ecco a voi Elisabetta […]
FIBBIE FIBBIE FIBBIE
Mangi dei cereali stantii che hai ritrovato in un angolo della credenza con dell’acqua del rubinetto – il cellulare già acceso che scarica le milioni di mail a cui dovrai poi rispondere – ti fermi un attimo a pensare a dove ti saresti voluto svegliare oggi e di quali gare prima o poi vorresti avere […]